| Il mare visto dal SAR Nell’ultimo quarto di secolo la meteorologia e l’oceanografia si
sono avvalse di dati di telerilevamento a microonde da aerei e da satelliti. Come è noto
la fortuna dell'impiego del Radar ad Apertura Sintetica (SAR) è dovuta alla possibilità
di operare di giorno e di notte e in ogni condizione meteorologica con elevata risoluzione
spaziale. Il Mar Mediterraneo, circondato da isole e coste frastagliate, ha potuto
avvantaggiarsi di tale tecnica, in particolare per l'osservazione dei fenomeni marini e
atmosferici a piccola scala (< 10 km) e per la rivelazione e quantificazione di
inquinanti di superficie.
Poiché il SAR invia un fascio radar con angolo di incidenza
obliqua, si ha segnale di ritorno solo quando la superficie marina è ricca di onde
gravito-capillari (lunghezze d'onda centimetriche) prodotte dal vento, che danno una
retrodiffusione dell’energia sufficiente per produrre immagini.
L’uso del SAR è particolarmente
utile:
- per osservare e misurare l'ondosità e in generale i fenomeni
marini che influenzano la rugosità superficiale del mare (correnti, vortici, onde
interne, ecc.);
- per visualizzare le caratteristiche spaziali dello strato limite
dell'atmosfera sulla superficie del mare;
- per l'estrazione del campo di vento sul mare ad alta risoluzione
spaziale;
- per la rivelazione di versamenti dolosi o accidentali di petrolio
greggio in acqua.
Data la complessità dei fenomeni che accadono sulla
superficie del mare, la maggior parte di natura impulsiva ed intermittente, siamo ancora
lontani dalla completa comprensione dei fenomeni connessi all'interazione aria-mare.
Quindi l'utilizzo oggi possibile delle immagini del SAR sul mare non può essere separato
dalla conoscenza dei meccanismi che influenzano le immagini stesse. Occorre destinare
ancora risorse alla ricerca scientifica su questo settore.
Il nostro progetto
Il presente progetto è composto di due aspetti separati ma
complementari.
- ricerca di base sui meccanismi fisici che influenzano
l’eco radar
- applicazione delle immagini SAR a problemi meteorologici ed
oceanografici quali:
- meteorologia costiera (studio degli effetti orografici sul vento);
- fenomeni atmosferici di trasporto verticale turbolento o
convettivo;
- studio delle proprietà direzionali del moto ondoso.
- inquinamento.
Per raggiungere gli scopi sopra elencati è necessario compiere
un esperimento in mare aperto durante la missione SRTM.

Piattaforma petrolifera dell'AGIP
"Barbara C" posizionata su un fondale
di circa 100 m.nell'Adriatico centrale al largo di Ancona
L’esperimento di interazione aria-mare-onde e.m. sarà
effettuato a bordo della piattaforma dell’AGIP "Barbara C" nel mare
Adriatico, ove saranno installati radar scattereometrici operanti alle bande S, L, C e Ku,
anemometri triassiali ultrasonici e Sodar Doppler phased array.

Scatterometro coerente, impulsivo operante
in banda L, S e C mod. ITS-600,
appositamente progettato per misure
del backscattering sul mare |
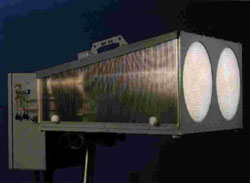
Scatterometro coerente, impulsivo operante
in banda Ku mod. ITS-800,
appositamente progettato per misure
del backscattering sul mare |
Durante la missione dello Shuttle, saranno
contemporaneamente misurati il backscatter radar da satellite e da piattaforma, la direzione
del vento, lo stress del vento e le temperature del mare e dell’aria.I dati ottenuti
forniranno serie temporali di eco radar, di frequenza Doppler del radar, di vento, di wind
stress e di flussi di calore. Dalla frequenza Doppler del radar si otterranno gli spettri
di frequenza delle onde che saranno confrontati con quelli ottenuti dalle immagini del
SAR. Saranno, inoltre, raccolti le proprietà direzionali del moto ondoso al largo di
Lampedusa per studiare le proprietà delle funzioni di trasferimento che modulano l'eco
radar del SAR in funzione della polarizzazione e della frequenza.
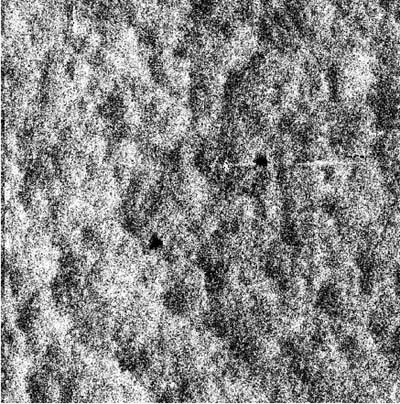
Dettaglio
di immagine SAR in banda C.
Si tratta di 1024 x 1024 byte con interpixel di circa 4.3 m.
L'intensità di bianco è proporzionale alla "Radar Cross Section".
Al centro è ripresa la piattaforma Acqua Alta (zona chiara);
le due macchie scure sono slick artificiali (versamento di due litri di alcool
oleico).
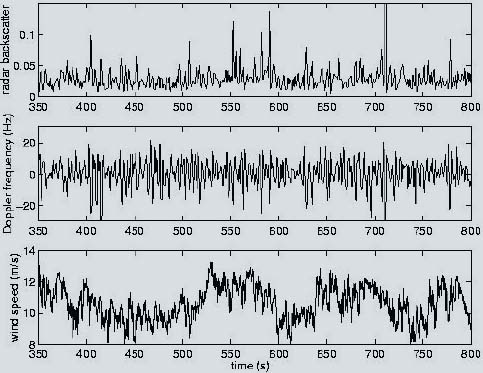
Esempio di serie temporali ottenute da
misure da piattaforma
In alto: serie temporale di radar backscattering in banda C.
In mezzo: frequenza Doppler radar.
In basso: velocità del vento. (ISDGM-CNR)
Secondo le condizioni ambientali che si verificheranno durante
l’esperimento, si studieranno le seguenti tematiche
- struttura spaziale dei sistemi atmosferici convettivi sul mare
(risoluzione > 25m);
- struttura spaziale del wind stress in qualsiasi regime di vento
(risoluzione > 25 m);
- proprietà spaziali del vento derivate da misurazioni SAR con
circa 1 km di risoluzione: il campo di vorticità atmosferico e i campi di velocità
verticale atmosferica (Ekman pumping);
- validazione di modelli elettromagnetici e statistici atti a
descrivere l’eco radar della superficie del mare;
- influenza dell’età dell’onda sul wind stress e
sull’eco radar, in acque più o meno profonde;
- ricostruzione dello spettro bidimensionale del mare tramite dati
SAR utilizzando tecniche di inversione implementate dai nostri teams di ricerca.
In relazione a quest'ultimo punto si è interessati al problema
del "retrieval" di spettri di onde mediante il metodo dei cross-spectra
applicato alle immagini in banda X. La differente lunghezza d'onda utilizzata per
l'acquisizione dell'immagine e la differente geometria di acquisizione del sensore sono,
infatti, parametri da tenere in considerazione quando si analizza un'immagine SAR. È
dunque importante capire come il metodo dei cross-spectra è legato a questi parametri e
come i parametri ambientali, primi fra tutti la velocità e la direzione del vento,
influenzano la risposta radar.
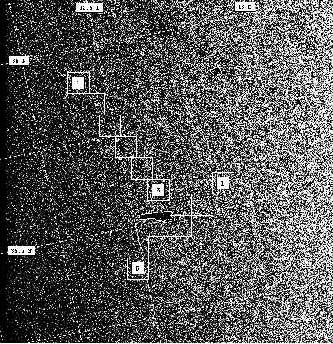
Figura 1: Immagine SAR ERS-2 acquisita il 13 novembre 1997
sul canale di Sicilia su un'area attorno all'isola di Lampedusa. Dall'immagine sono state
selezionate due sequenze di finestre da utilizzarsi per le successive elaborazioni.
|
In previsione della missione SRTM, è stata messa
a punto una procedura per effettuare un confronto fra i risultati ottenuti con un metodo
classico di inversione (Hasselmann & Hasselmann) e quelli ottenuti con il metodo dei
cross-spectra.
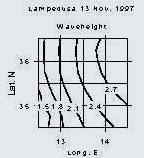
Figura 2: Altezza dell'onda per un'area di
2x2 gradi attorno all'isola di Lampedusa. Questo dataset, ricavato dall'ECMWF come output
di un modello d'onda (WAM), è il primo dei tre parametri utilizzati per la procedura di
inversione. |
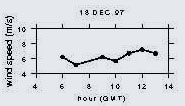
Figura 3: Andamento della velocità del vento
il 13 novembre 1997 (la direzione rimase pressochè costante compresa in un intervallo fra
300° e 310°). I dati sono forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica e
costituiscono il secondo parametro di input per la procedura di inversione.
Tale procedura utilizza, come dati di input, dataset
dei tipi riportati in figura 2, 3 e 4 e, testata sull'immagine in figura 1, ha permesso di
ottenere risultati (figura 5a, 5b, 5c) che mostrano un buon accordo tra il risultato
ottenuto con il metodo di HH, che necessita di un "first-guess spectrum" per
l'inizializzazione, e quello ottenuto con il metodo dei cross-spectra che, viceversa, non
necessita di alcuna informazione supplementare. In entrambi i casi risulta che,
contrariamente allo spettro WAM, l'energia del picco è tale da mascherare la
distribuzione del sistema di vento. Questo potrebbe essere dovuto ad un diverso valore,
rispetto a quello teorico, da attribuire alla funzione di trasferimento RAR in relazione
alla velocità del vento. Lo studio della relazione tra MTF RAR e velocità e direzione
del vento sarà uno degli obiettivi da perseguire con i dati rilevati in situ. Infine, si
può notare che il sistema di swell non è presente nello spettro del mare recuperato. Il
motivo potrebbe essere dovuto al fatto che l'altezza significativa (circa 0.4 m nello
spettro WAM) risulta troppo bassa e quindi non rilevabile dal SAR a bordo dell'ERS2. |
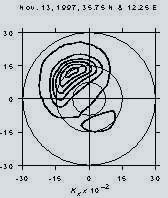
Figura 4: Spettro delle onde per il nodo a
35.75 N e 12.5 E (leggermente a ovest dell'isola di Lampedusa) che include sia un sistema
di wind sea, sia uno di swell che si muove in direzione SW. Questo dataset, ricavato
dall'ECMWF come output di un modello d'onda (WAM), è utilizzato come terzo parametro di
input per la procedura di inversione. |
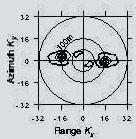
Figura 5a: Spettro SAR osservato. |
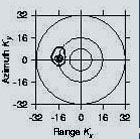
Figura 5b: Spettro ottenuto con il metodo di
inversione di HH. |
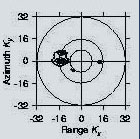
Figura 5c: Spettro ottenuto con il metodo dei
cross-spectra. |
E' inoltre prevista un'attività mirata alla
verifica di modelli per la descrizione dello scattering elettromagnetico dalla superficie
marina. A tal fine risultano di fondamentale importanza i dati di verita' in situ,
acquisiti contemporaneamente ai dati SAR. I modelli elettromagnetici verranno utilizzati
per la messa a punto, la verifica e l'interpretazione dei risultati ottenuti mediante
algoritmi di inversione, per il recupero dello spettro marino da quello dell'immagine SAR.
E' prevista la raccolta di dati satellitari utili a
caratterizzare lo stato dell'atmosfera, con particolare riferimento alla temperatura, al
contenuto di vapor d'acqua e acqua liquida, alla presenza e alle caratteristiche dei
sistemi nuvolosi ed, eventualmente, all'intensità di precipitazione alla superficie. Si
prenderanno in considerazione i dati Meteosat (radiometro visibile e infrarosso,
risoluzione circa 2 km), DMSP-SSM/I (radiometro a microonde a 7 canali nell'intervallo
19-85 GHz, risoluzione di circa 15 chilometri alla frequenza di 85 GHz), DMSP-SSM/T
(radiometro a microonde operante nella banda dell'ossigeno). E' prevista l'analisi dei
dati dei radiometri per la generazione di prodotti sullo stato dell'atmosfera utilizzando
i dati a mare (vento, temperatura della superficie, onde) per la modellizzazione
dell'effetto della superficie sul segnale radiometrico.
Bibliografia |